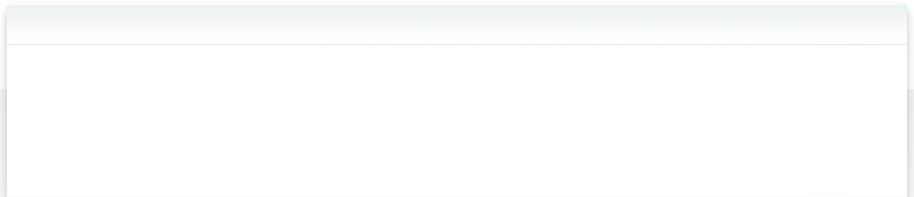Davide Cerullo - La vita è salva perché qualcuno si ostina a sperare
Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze non sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perchè sembrano assurde e inattuabili e le conservo ancora, nonostante tutto, perchè continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo.
Anna Frank
Credo che quando si è depositari di dolori o storie che un bambino non dovrebbe mai vivere, ricordarle o raccontarle sembra triste, ma la mia vita è stata segnata, anche da una scoperta straordinaria.
Se ciò può servire a dare speranza, ad aiutare a risalire dal fondo che si è andati a toccare per aver intrapreso una direzione sbagliata, per me è importante raccontare, narrare, informare le nuove generazioni ciò che ho passato.
Come è necessaria la torcia sul casco del minatore, per indicargli il cammino, per me oggi, che ho vissuto a Scampia - Napoli, un quartiere in lista d’attesa in fatto di diritti, credo che tutti siamo portatori di cambiamento dove ciascuno può improvvisamente sentirsi liberato.
Ricordo che quando mio padre ebbe l’occasione, nel 1982, di avere un lavoro presso una ditta di bestiame di un ricco commerciante di Cassino, partimmo da Scampia per andare ad abitare in un paesino chiamato Panaccione in provincia di Frosinone con la speranza di trovare un po’ di fortuna, vista la povertà in cui versava la mia famiglia, anche perché eravamo 14 figli e restare a Scampia non ci avrebbe aiutato, allora seguimmo tutti nostro padre nella sua scelta.
Ma molto presto mia madre capì che lì, in quella campagna deserta, lontano da tutti e tutto la faceva sentire sola ed ancor più sola da quel marito che tornava a casa quando le porte di altre case dove lui era solito andare erano chiuse, ma lei continuava a portare quel peso inevitabile per amore di noi figli. Ma un giorno, un triste giorno dopo l’ennesimo litigio con mio padre, che usava le sue enormi mani solo per picchiare, da quel litigio mia madre riportò una grossa ferita per un pugno sul sopracciglio dell’occhio destro, dieci punti di sutura. Allora mia madre stanca ma decisa fece la dolorosa scelta di ritornare a Scampia. Noi tutti andammo con nostra madre perché nostro padre era violento.Nessuno dei miei fratelli si sarebbe sognato di rimanere.
Quando sono arrivato a Scampia avevo solo 7 anni. Scampia non era ancora invasa dalla malavita. Di tanto in tanto andavo a scuola e quando non ci andavo la strada mi diventava madre, passavo più tempo in strada che con mia madre, passavo più tempo in strada che con i miei giocattoli, anche se ne ho visti veramente pochi.
La strada è stata per me un vero disorientamento, la mancanza di scuola è stata una vera e propria sconfitta, e una vittoria per la camorra. La mancanza di mio padre fu una ulteriore sconfitta. Più passava il tempo e più non capivo quale fosse la direzione giusta da prendere, non avevo nessuno che me la indicasse, non avevo punti di riferimento su cui posare il mio sguardo, e venendo in un certo senso adottato dalla strada non ho potuto che assorbire quello che lei insegna e che la sua cultura crudele partorisce.
Intanto crescevo e mia madre, come pure i miei fratelli, perdevano sempre di più autorità su di me, cominciavo a non ascoltarli più, il richiamo della strada era più forte dei loro schiaffi, delle loro punizioni.
A soli quattordici anni non so perché, forse era l’unica cosa in cui stando in strada avevo imparato a credere, mi ero messo in testa di voler diventare un boss, o perlomeno un camorrista. Sentivo crescere in me un necessario bisogno di appartenenza, è stato un qualcosa che è avvenuto quasi in automatico, come se io per tutte quelle cose che avevo visto, per tutte quelle persone che avevo praticato fossi predestinato a fare il camorrista, insomma una fase obbligatoria per tutti quelli come me a cui era stato fatto credere che il realizzarsi della propria vita avveniva se entravi a far parte di un sistema criminale e spietato.
Il problema non era più la povertà della mia famiglia, né il fatto che nostro padre ci avesse abbandonato, il problema ero io.
A 14 anni mi sono messo a vendere morte: la droga. La portavo direttamente in piazza, ero diventato un malavitoso; quando la polizia passava dove io la vendevo, neanche mi guardava. Forse perché ero piccolo e non davo nell’occhio.
Scampia cambiava sempre in peggio, e con lei, la mia vita. Il mito del forte, del boss cresceva in me spropositatamente.
Mi convincevo sempre di più di voler far parte di quel grande circo del male senza logica né filo conduttore, tenuto insieme solo dal sangue e dalla sete di denaro, il denaro prima di tutto il resto, il denaro prima della vendetta, il denaro prima della vita. Tutti quei cattivi maestri che mi circondavano avevano un solo obiettivo da raggiungere: diventare come i nostri capi, farsi un nome.
Ero cresciuto per quello che facevo ed ero considerato uno capace di fare molta strada nel mondo della malavita.
A sedici anni sono stato arrestato per la prima volta. Ho tentato invano la fuga, ma venni preso subito. La cosa strana fu che venni arrestato dai carabinieri che erano sottoposti al mio capo. Arrivarono nella piazza dove spacciavo per ritirare la mazzetta, erano in due e gli diedi trecentomila lire. Forse mi arrestarono perché per un certo periodo si erano visti rifiutati la paga della loro vergogna. Con il mio arresto vollero far capire che se non avessero ricevuto più denaro non ci avrebbero lasciati in pace.
La corruzione è stata l’elemento forte della crescita e dell’espansione del fenomeno criminoso in cui versa la nostra cara Napoli, specialmente Scampia e i quartieri periferici. Perché la camorra, quella forte, quella vera, quella in alto, quella che siede nei palazzi di lusso e del potere, quella che magari ti fa credere che combatte il crimine organizzato è in realtà l’ape regina che manovra tutte le forme di mafia. Perché la mafia è anche quella che usa modi puliti per fare le cose sporche.
È un grave errore definire, mafioso, camorrista un piccolo gruppo di delinquenti da quattro soldi, quelli sono in ogni città.
La mafia è in ben altri luoghi è in ben altre assemblee, il mafioso è un banchiere, il mafioso sta in parlamento.
Quando mi arrestarono mi ammanettarono e mi fecero entrare in macchina. Provai una sensazione di forte solitudine, un abbandono struggente. Mai mi ero sentito così solo. Ad un tratto vidi mia sorella Maria, tentò di avvicinarsi alla macchina per parlarmi, ma non le fu permesso. Partimmo a gran velocità. Mi voltai per vederla, era rimasta lì al centro della strada, impotente, immobile. Diventava sempre più piccola, si allontanava sempre di più da me. A quel punto piansi. Mi portarono nel carcere minorile dei Colli Aminei dove incontrai un altro ragazzo con le mie stesse convinzioni e con una assetata voglia di vendicare suo padre ucciso dalla camorra. Uscimmo insieme dopo tre giorni di punizione, ma ritrovai la sua faccia sui giornale una settimana dopo: sua madre ne denunciava la scomparsa. Lupara bianca. Aveva solo 17 anni.
Quando dopo tre giorni uscii, ricordo che a Scampia, quando arrivai, fecero i fuochi d’artificio per farmi festa, come uno che ha superato l’esame per poter essere ammesso in una scuola superiore.
Tutto questo accresceva in me la convinzione di un futuro tra i boss o da boss. Non nascondo che ripensare in cosa credevo mi fa veramente ridere, è ridicolo, fare il camorrista. Sì è uno schifo, ma è anche ridicolo, banale e stupido.
Il camorrista è la persona più morta, più senza futuro che io abbia mai conosciuto.
Credo che il primo elemento che mi ha portato a sbagliare direzione sia stata la mancanza di cultura. Non essendo andato a scuola mi sono lasciato soggiogare dalla cultura di morte che ti insegna la malavita. La sua forza, il suo dominio lo esercita proprio su chi di cultura, di scuola non ne sa niente. Se c’è un potere grande che mette in fuga la camorra questo è proprio la scuola.
Io non ho vissuto serenamente la mia gioventù proprio per la mancanza dell’essenziale, dell’amore, del bello, del senso del vero e della scuola.
Ricordo una mattina di gennaio: faceva un freddo cane quando mia madre venne nella mia stanza a svegliarmi. Ancora stordito da una notte da schifo in discoteca, tentò di svegliarmi per dirmi che c’erano due persone che mi cercavano, erano ’e guagliun’ ’ro zii: mandati dal capo. Mia madre, che in un modo assillante mi raccomandava di stare attento, avevo solo 15 anni, mentre i due (amici) erano molto più grandi di me.
Lo zio, il capo, così chiamato nel gergo malavitoso per evitare di pronunciare il suo vero nome tutte le volte che si faceva riferimento a lui, mi mandava a chiamare perché c’era una cosa urgente da sbrigare e io, secondo lui, ero la persona giusta. Era un periodo nero, i suoi nemici, molto più potenti di lui, gli avevano fatto sapere che era arrivata la sua ora.
Avevano già scritto la data della sua morte. Lo zio sapeva di avere ancora una carta da giocare. Era un fedelissimo di Paolo Di Lauro, così decise di uscire di casa per andare da lui e chiedere la grazia. Mi mandò a chiamare perché ero minorenne e perché sapeva che io non avevo paura, pur sapendo che lo volevano uccidere. Arrivammo a casa sua passando da vie secondarie e porte segrete. Si era chiuso in casa, temeva addirittura di affacciarsi al balcone.
Quando arrivammo da lui mi venne incontro, mi strinse la mano dandomi due baci come si salutano i boss, poi chiamò Giovanni, l’autista, dicendogli di prendere subito la macchina perché dovevamo andare Miezz all’Arc. L’autista prese una Citroen, insospettabile, lunga e tutta picchiata, la preparò all’interno del palazzo privato, poi, mi invitò in camera: aprì il cassetto del comò e tirò fuori una grossa pistola a tamburo. Era la sua pistola personale. A vederla mi brillavano gli occhi, poi lui stesso mi alzò il cappotto e mi infilò l’arma nella cintura. Ero orgoglioso di me stesso, appagato, mi sentii in quel momento il padrone del mondo, non avevo paura di nessuno. Poi scendemmo per una scala all’interno del suo palazzo per arrivare alla macchina, ci mettemmo tutti e due sui sedili posteriori un po’ curvati e ci dirigemmo verso Via Cupa dell’Arco per incontrare un boss, uno dei capi indiscussi di Secondigliano, Paolo Di Lauro detto Ciruzzo ‘o milionario, il solo che secondo il mio capo poteva allungargli la vita.
Arrivammo davanti ad un grosso portone lo zio si guardò bene prima di scendere per poi, come un lampo, schizzare fuori dall’auto, dirigendosi verso il portone mentre io e l’autista aspettammo in macchina. Perché vedere a Ciruzzo era permesso solo a pochi suoi fedeli.
Aspettammo circa mezz’ora, vedemmo tornare lo zio con un’aria più rilassata. Lo zio era un tipo che si fidava poco, ma sapeva bene che oltre quel grosso cancello di ferro c’era un potere difficilmente violabile da parte di altri capi. La parola di ‘o milionario era una, quindi una garanzia. In quel momento io mi sentii forte, importante.
Per anni sono rimasto al servizio dello zio, per lui ho subito un agguato ritrovandomi, per fortuna, solo con quattro proiettili ad entrambe le gambe e quaranta giorni di ospedale.
Avevo solo 16 anni, per lui ho rischiato di uccidere. Fu solo per uno spostamento del designato che l’esecuzione non andò a segno, per lui e per la mia convinzione in ciò che credevo avrei fatto qualsiasi cosa. Per lui mi sarei fatto uccidere, per me lui contava più di tutti e tutto, prima di mia madre c’era lui.
In fondo questo è quello in cui si arriva a credere e che si arriva a fare quando si insegue il non senso della vita, perché quando ti lasci corrompere, imprigionare la mente dalla malavita, automaticamente smetti di essere un uomo, di essere libero, felice, vantandoti peraltro di ciò di cui avresti solo dovuto vergognarti.
Il malavitoso è l’essere più solo e infelice al mondo, si illude quando tutti gli fanno credere il contrario.
La polizia era sulle mie tracce, ma per arrestarmi decise di aspettare che io compissi 18 anni per potermi punire seriamente. Ma intanto me la godevo, con un milione di lire al giorno, potevo permettermi tutto.
La prima cosa che facevo insieme a tutti gli avvoltoi che mi circondavano e mi consideravano un grande, smesso il mio turno da spacciatore, davo ad uno di loro dei soldi e lo mandavo a comprare la cocaina e l’hashish per la serata. Quasi tutte le sere andava così, e così crescevo sentendomi sempre più forte in quello che facevo, il migliore, immortale. Ma per fortuna, lo Stato, alcune volte, è più forte dell’illegalità, della camorra.
La polizia a diciotto anni e un giorno mi arresta con l’accusa di spaccio. Per me si aprirono le porte del carcere di Poggioreale: un vero inferno.
Come benvenuto le guardie, insieme alle coperte e al cuscino, mi diedero tanti schiaffi e tanti calci senza nessun motivo. Forse un motivo c’era, dovevo capire da subito che lì comandano loro e io non ero niente e nessuno.
A Poggioreale ho vissuto giorni bui, lì, dove la speranza è condannata a morte, dove le persone sono considerati gli ultimi della terra, dove la pietà non esiste, si sta come Cristo in croce.
Un giorno tornando dall’ora d’aria trovai sul mio letto una piccola bibbia. Quasi mi vergognavo a toccarla perché avevo paura di essere considerato dai compagni di cella un buono a nulla, uno che non sa da che parte stare.
Nella malavita devi dimostrare di non avere sentimenti. Mi guardai bene che nessuno mi vedesse, presi in mano la bibbia, l’aprii e notai che in alcune pagine era scritto il mio nome per tre volte. Per un attimo mi sentii parte di quella storia e cosi commisi un furto cartaceo: strappai tre pagine e quando uscii le portai con me, pagine che conservo ancora oggi.
Quando uscii da Poggioreale ripresi a fare la vita di sempre, con qualche grado in più, anche per il male che avevo subito a Poggioreale. Mi era sorto dentro un sentimento di vendetta verso la vita in generale. Ma proprio da quel fango in cui ero dentro fino al collo, in mezzo a quella Scampia che è sulla bocca di tutti e nel cuore di nessuno, proprio lì io sono rinato.
Sono rinato perché c’é stato qualcuno che non si è rassegnato all’apparenza, qualcuno che non aveva l’abitudine di archiviare la speranza e che non ha avuto paura di mescolarsi con una sporca realtà, ma si è affiancato ad essa e mi ha fatto sentire la sua presenza, la sua amicizia.
Il suo nome è Aniello Manganiello, un prete che ha le mani del contadino, i piedi del montanaro e il cuore del monaco. Uno che mi ha raccontato un percorso, uno che è convinto che la vera ricetta della felicità come ne era convinto Giovanni Papini, è quella di aiutare i caduti a risorgere, i lacrimanti a sorridere, i disperati a sperare. E quando man mano mi diventava sempre più chiaro che era possibile pensare e vivere da persone libere, che si poteva vivere una vita diversa, più autentica, più piena d’amore anche se si e nati a Scampia, allora ho detto no.
Basta, non ci sto più, negandomi al sistema, prendendo le distanze, remando contro a chi prepotentemente pensava di farmi credere di potersi sostituire allo stato, a chi pensava di poter decidere su tutto e tutti, a chi pensa in una parola di essere uomo ma che di fatto e più simile alle bestie. Allora ho detto: no! Riappropriandomi di me stesso, riprendendo la mia libertà, la mia identità, i miei sogni, la mia vita. E come Aniello ci sono state altre figure che vedevano lontano; Suor Monica Redolfi, che per Scampia si è spesa tanto.
Un giorno, avvicinandomi sotto alla Vela Celeste mi disse: ma tu sai chi è un camorrista? Io dissi sì, uno come me, uno che ha tanti soldi, donne, macchine, il potere.
Lei rispose, hai detto bene, ma ti sei dimenticato di una cosa. Cosa? Risposi io titubante.
E lei: il camorrista è uno stupido che si scava la fossa con le sue mani. Io rimasi turbato dalla forza delle sue parole.
Parole che non mi lasciarono più in pace. In me, anche se con qualche incidente di percorso, ho visto realizzarsi quello che cantava De Andrè: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”.
Ero io quel fiore, ero io quel fiore che rinasceva da letame della malavita, ero io che risorgevo proprio dal cuore di Scampia. Quelle pagine strappate da quel libro sacro nel buio di una cella si riaprivano per diventare vita in me e strapparmi dalle braccia del male.
Rinascevo da quella Scampia che tanti credono, che chi ci abita, per salvarsi sia necessario scappare. Ma il problema di Scampia non è solo la malavita, perché Scampia non è solo Gomorra, per fortuna, ma l’incapacità di credere nella possibilità del cambiamento. Perché se io sono quel seme caduto in quell’angolo di Scampia dove a fare da padrone è la camorra ed il piacere per il crimine: se da quel buio sono rinato, è perché qualcuno si è ostinato a sperare, a credere, a gridare. Questo significa che se ognuno fa qualcosa è segno che si può fare molto. Fino a quando ci saranno persone, specialmente bambini, che vivono situazioni inaccettabili, inconcepibili, la mia felicità, il mio essere libero risulterà uno scandalo.
La mia libertà risulterà uno scandalo se non si lascerà disturbare dal grido lacerante di un nostro simile oppresso dell’ingiustizia, dal malessere camorristico e sociale e di questo la chiesa più di chiunque deve essere la prima a doversene fare carico oggi come mai prima.
Vorrei concludere con un pensiero che mi sono ritrovato tra le mani un giorno che presentavo il mio libro “Ali Bruciate - I bambini di Scampia” nel quartiere lotto P chiamato comunemente case dei puffi insieme a padre Fabrizio Valletti, un meraviglioso gesuita che da undici anni promuove presa di coscienza e formazione a Scampia.
Credo che questo scritto appartenga ad una voce libera di Scampia, una voce indignata, incazzata che reclama non solo per se stessa, ma per tutti i diritti.
Una voce che chiede il risarcimento di una vita finalmente normale per i figli di Scampia, una vita degna di questo nome, una vita normale e possibilmente non lontano dalla propria terra, una vita normale restando dove si è nati.
Napoli è una Città che non tollera, non perdona chi se ne va, perché è grande il tuo amore per lei. Napoli non si rassegna al fatto che primm’ t’ha da ’mparà e dop’ t’ha da perdere.
Dice così:
Siamo stanchi di sentirci definiti degli sgarrupati, giudicati dei senza speranza.
Siamo stanchi di chi ci ruba la dignità, i diritti, la voce.
Siamo stanchi di chi ci ruba: pure i sogni.
Siamo stanchi di una città compiaciuta, continuamente soggiogata, sporcata dal potere camorristico.
Siamo stanchi dei furbi, dei corrotti, vogliamo una vera giustizia, legalità, ed una società che dà più importanza al nostro avvenire.
Siamo stanchi di restare a guardare e sentire la solita litania: “fatti i fatti tuoi, è tutto a posto”.
Siamo stanchi di assistere impotenti di fronte all’indifferenza di tanti che non hanno il coraggio di mettersi in gioco per cominciare a provare a cambiare veramente qualcosa, perché siamo stanchi di una mentalità distorta e disumana, stanchi di chi vuol far passare per giusto un mondo assurdo.
Siamo stanchi perché vogliamo rimetterci in piedi, svegliarci, aprire gli occhi alla vita, camminare a testa alta, senza paura.
Siamo stanchi di chi si continua a nascondere dietro al muro dell’ omertà, facendo prevalere la paura e il silenzio.
Siamo stanchi di chi sa solo dirci “fujtevenne” (scappate).
Noi non vogliamo avere paura di camminare liberi per le nostre strade, rivogliamo la nostra libertà, dignità, bellezza.
Vogliamo noi pure avere il diritto, come tutti e chiunque, di coltivare le nostre ambizioni, i nostri ideali.
Noi non vogliamo né capi né padroni, ma solo un po’ d’amore, per avere la possibilità di ritornare a sorridere, a essere liberi e felici, per tutti, con tutti e sempre. Amen
Casa della Solidarietà - Rete Radié Resch di Quarrata
Associazione di solidarietà internazionale